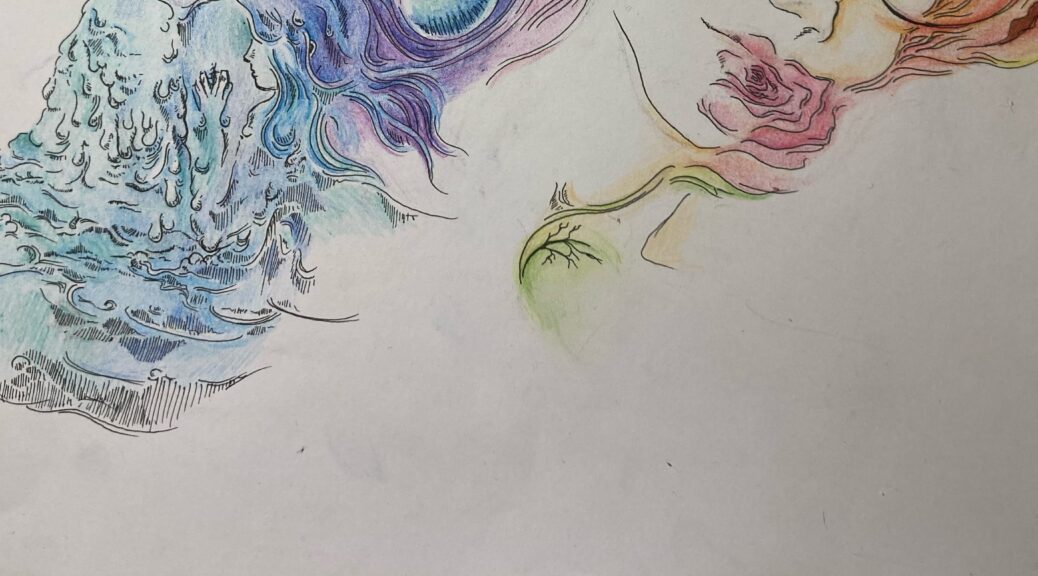Giulia Rista, in questa sua
composizione, si concentra sul concetto di arte come forza creatrice. Il testo
è stato sviluppato nell’ottica del corso Scritture delle origini. I
miti e la scienza, Letterature comparate B, mod. 1-2, prof.ssa Chiara
Lombardi.
Il mio racconto si pone l’obiettivo di nobilitare l’attività artistica, sia essa letteraria, figurativa o di altro genere. Il personaggio principale trova nella pittura non solo un rifugio, ma lo strumento per una nuova genesi del suo mondo, il quale subisce una vera e propria trasformazione; in questo senso, la figura di Milo viaggia in parallelo con i grandi protagonisti dei miti delle origini. Ho tratto ispirazione, per l’ambientazione di questo testo, da Zaandam, cittadina olandese dove Claude Monet ha operato per svariati anni: ho scelto di riportare un suo dipinto che mostra in maniera particolare il trionfo del colore sul grigio piattume della realtà, contrasto a mio parere emblematico del percorso di formazione cui il protagonista della storia è sottoposto.
*
Milo era venuto al mondo in un giorno d’inverno, uno di quelli in cui il peso inerte dell’aria grava sulle tue spalle e ti schiaccia al suolo. I suoi occhi si erano aperti su uno scenario di pareti grigie e facce indistinte, mentre, fuori dalla finestra, il cielo plumbeo pareva una lastra di metallo su cui la mole informe dell’ospedale si specchiava.
La stessa vena di opacità era
riecheggiata nei successivi anni della sua vita, spesi tra i corridoi immobili
della scuola e gli anfratti rinsecchiti del giardino di casa; più tardi, si era
iscritto a economia e aveva intrapreso la carriera di commercialista: forse non
aveva perseguito una passione bruciante, ma si era guadagnato un posto nel
mondo e tanto bastava.
Nel frattempo, aveva avuto una buona dose di amici e perfino alcune donne, ma non poteva dire di aver mai provato alla bocca dello stomaco quella sensazione di cui sentiva parlare con sempre maggiore frequenza, e che si diceva fosse in grado di domare anche i cuori più reticenti. Nel pieno crepuscolo della seconda decade della sua vita, infatti, Milo si era reso conto che tutti attorno a lui si ostinavano a menzionare il grandioso sentimento che inizia per A, e a chiedere quando si sarebbe deciso a sposare Agatha, la sua ragazza: era stato più per mettere a tacere quello sciabordio di voci che per altro se alla fine i due si erano sposati davvero.
A quarant’anni, Milo ancora non
riusciva a smettere di rimuginare sulla propria incapacità di amare la moglie.
La notte, quando la camera era silenziosa e la saracinesca abbassata, teneva
gli occhi sbarrati a fissare l’oscurità e corrugava la fronte. Perché non
provava niente? Era sempre andata così: si era compiaciuto dei sentimenti
mediocri, delle abitudini ordinarie e dell’aspetto lineare e sbiadito della sua
intera esistenza.
Una mattina, il peso dei pensieri
gli sembrò insopportabile, e provò il desiderio impellente di allontanarsi da
una realtà che d’improvviso gli andava stretta. Così prese la valigetta da
lavoro, uscì dalla porta di casa e si incamminò per le strade deserte e
polverose.
Sentiva un’intercapedine dentro,
come se il sole del mattino fosse una sorta di gigantesca aspirapolvere che gli
stava risucchiando l’anima. Attraversava il lungo ponte che tagliava in due la
città: lontano, sull’acqua sotto di lui, vedeva il riflesso dei grandi mulini
che costeggiavano il lago. Una brezza gelida gli sferzava le guance, quasi
ferendolo.
Fu solo quando il suo respiro si
fece corto che Milo si fermò di colpo: i gomiti appoggiati alla ringhiera, si
sforzò di respirare a fondo, mentre scrutava l’acqua torbida al di là del
parapetto e immaginava di lasciarsi cadere a peso morto. Di nuovo, scorse il
riflesso di un grande mulino, un cono dall’intonaco verde pallido che distava
solo di qualche metro dal ponte. Un ricordo affiorò alla sua mente: Agatha che,
con la testa adagiata sulla sua spalla e un sorriso sereno in volto, gli
confessava di amarlo, lasciando che le sillabe ruzzolassero fuori dalla bocca e
che il vento le trasportasse verso uno di quegli imponenti edifici. Forse le
pale avevano catturato le parole e le avevano fatte proprie per sempre, perché,
anche se Milo non aveva replicato, un silenzio inattesamente rilassato era
calato tra i due, e Agatha non aveva preteso alcuna risposta; lui l’aveva
scrutata in volto, convinto di scorgere del disappunto, ma non aveva trovato
altro che la stessa pace di poco prima. Dieci mesi più tardi si erano sposati.
Ora Milo avvertiva il battito
cardiaco normalizzarsi, e una nuvoletta di condensa si faceva largo tra le sue
labbra ad ogni respiro. Fece per riprendere il cammino lungo il ponte, quando
con lo scarpone urtò qualcosa di rigido che andò a sbattere contro il parapetto
e produsse un rumore metallico; una volta raccolto l’oggetto da terra, Milo constatò
che si trattava di un taccuino rilegato in cuoio ormai vecchio, e che le pagine
ruvide, benché sgualcite dall’umidità, erano perlopiù intonse. Un sorrisetto
sbilenco gli sollevò un angolo della bocca nel momento in cui ricordò che, da bambino,
un blocchetto da disegno simile a quello aveva rappresentato per lui il più
grande tesoro.
Come gli piaceva disegnare! Non
lo aveva più fatto dai tempi dell’infanzia, troppo preso dall’etica del ceto
medio e intento ad accantonare tutto ciò che non gli avrebbe portato profitto. Gettando
una rapida occhiata alla valigetta, e voltandosi poi a perlustrare il ponte,
un’idea percorse furtiva l’anticamera del suo cervello: chissà se ne era ancora
in grado. Si chinò, aprì la valigetta ed estrasse una matita.
Visto attraverso le sbarre del
parapetto, il mulino sembrava più snello e più alto: Milo, seduto a terra, ebbe
qualche attimo di esitazione, ma poi iniziò a tratteggiare i contorni
dell’edificio, curandosi appena di rimanere fedele al soggetto. Era trascorsa solo
una manciata di secondi, quando gli parve di sentire un vago pizzicore al
braccio; non avrebbe saputo descriverlo, ma era come se il foglio fosse pervaso
da una lieve scarica elettrica che attraversava il legno della matita e si
propagava nelle dita della sua mano. Inizialmente ne fu quasi infastidito, ma
poi la sensazione iniziò a farsi sempre più piacevole, fino ad avvolgerlo come
un vento caldo. Nel momento in cui iniziava a delineare il profilo delle pale,
Milo era ormai preda di una vera e propria euforia che gli faceva sgranare gli
occhi e tracciare con la matita segni sempre più rapidi. Per la prima volta
dopo tanto tempo, si sentiva felice, come se la sua intera esistenza non fosse
stata altro che un preludio a quel momento di puro piacere e stesse iniziando
solo allora a vivere.
Improvvisamente, un pensiero gli
fece alzare di scatto la testa. “Ci vuole un po’ di colore” si disse, il viso
tornato serio e una nota di urgenza nella voce. Poi si allontanò a grandi passi
dal luogo della sua arte. Era la seconda volta, quel giorno, che un impulso
involontario lo spingeva a correre.
*
Entrare in casa era stato come ritrovarsi immerso nello smog della città dopo aver respirato a pieni polmoni l’aria limpida e sottile della montagna, ma ora tornava a inebriarsi di quella purezza: dipingeva, e le pennellate non si limitavano a decorare le pagine del blocchetto, ma coloravano pian piano la sua stessa vita, fino a quel momento grigia e fiacca e spenta e labile. Per la prima volta i suoi sensi si acuivano, il cielo si faceva più terso, l’erba era di un verde più brillante e, un paio di metri più in là, il lago era trasparente. Sotto il suo tocco, il disegno del mulino sbocciava come un fiore, e le pale rosse parevano fragole di cui riusciva quasi a sentire il profumo, forgiate nel fuoco della sua frenesia.
“Ma l’amore!” gridava. “L’amore!” Ora lo sapeva anche lui: provava quello che gli altri provavano, un sentimento che si schiudeva nel suo petto come uova raccolte di fresco. Sollevava gli occhi al sole di ottobre e lo ringraziava per la sua luce. Apriva le braccia e chiedeva al mondo di pervaderlo, gli offriva la sua protezione incondizionata. Avrebbe sacrificato il suo corpo per lui, ogni cellula scissa dalle altre e donata al cosmo affinché facesse di sé qualcosa di più.
“Sono nato per essere un artista”
si ripeteva. Malediceva tutto quello che l’aveva fatto sentire piccolo o
mediocre o insignificante. Doveva dipingere, e sentiva quell’esigenza
esplodergli dentro e fare a brandelli la sua vecchia anima, ormai secca e
raggrinzita. Ne aveva bisogno, perché la realtà non gli bastava.
Il resto della mattinata
trascorse veloce, ma Milo non rincasò per pranzo; voleva, doveva rimanere lì,
anche se aveva terminato il primo disegno e si accingeva a iniziarne uno nuovo.
Nemmeno a pomeriggio inoltrato si decise a rientrare, e fu solo quando il sole
era tramontato da un pezzo e il buio gli impediva di distinguere nitidamente i
colori che si trovò costretto a interrompere il suo operato. “Però non posso
andarmene” si disse. Decise di dormire sul ponte: era convinto che, una volta
spiegato tutto ad Agatha, lei avrebbe capito.
Si concluse così quello che gli era sembrato il primo giorno della sua vita.
Quella notte non dormì, intento a
studiare nuove angolazioni per i suoi dipinti e a rimuginare sulle tecniche da
impiegarsi; una volta sorto il sole, non volle perdere tempo e si mise subito
all’opera. I piedi gli dolevano per le ore trascorse al freddo, non sentiva più
la punta delle orecchie e le dita presentavano piccoli tagli arrossati, ma
nulla di tutto ciò aveva importanza: quel giorno avrebbe riprodotto il mulino
blu, e poi quello giallo, e poi tutti e due insieme.
Nel tardo pomeriggio, Agatha lo
trovò mentre mordicchiava la matita. “Milo” gli corse incontro. “Mi hai fatta
stare in pena. Stai bene?”
Milo le disse che stava bene, che
aveva trascorso la notte al motel perché era molto stanco e che sì, aveva
mangiato, al chiosco di panini più in là. Non era vero: non toccava cibo da più
di un giorno; eppure il suo stomaco non sembrava patire la fame. Il suo corpo
era impermeabile alle comuni esigenze umane, e Milo quasi le ripudiava.
Agatha era preoccupata, ma il
viso di suo marito irradiava per la prima volta una gratificazione tale che
alla fine decise di concedergli ancora qualche ora con i suoi schizzi,
facendosi promettere che l’avrebbe rivisto a cena.
Milo, però, non aveva intenzione
di tornare. La vita non gli mancava: quella era vita. Temeva il momento in cui
avrebbe rivisto la sua casa fatta di mattoni, e cercava di allontanarlo da sé
il più possibile; ora sapeva che non si poteva essere uomini e felici, ma
artisti e felici… Questo forse sì.
Non tornò da Agatha neanche a
tarda notte. Il giorno dopo, la donna si presentò nuovamente sul posto:
nonostante i movimenti frenetici delle mani, Milo era pallido, smunto; i suoi
occhi erano cerchiati e ridotti a fessure, come se si rifiutassero di rimanere
aperti, e le guance scavate gli conferivano l’aspetto di un malato. Indossava
gli stessi vestiti da quasi tre giorni.
Agatha tornò a reclamare la sua
presenza più volte, ma fu tutto inutile: i giorni passavano e Milo non si
decideva a schiodarsi da lì. Era in una sorta di trance, e il suo mondo finiva laddove
i contorni del blocchetto da disegno cedevano il posto alla realtà.
“Ora basta.” Agatha si sforzava
di suonare il più autoritaria possibile, ingoiando la frustrazione che le
riempiva il petto. “La tua passione ti sta logorando. Devi venire a casa, metterti
dei vestiti puliti, tornare al lavoro. Non te lo ripeterò.”
Milo continuava a tenere gli
occhi fissi sul blocchetto. Sembrava non sentirla nemmeno.
Esausta, Agatha alla fine si
sedette accanto a lui. “Milo.” Ora la sua voce era rotta: le parole tremolavano,
sospese nella luce fioca. “Voglio portarti via da qui.”
Per la prima volta dopo diversi
giorni, Milo alzò lo sguardo e la scrutò, gli occhi grandi come la luna che
cominciava a spuntare in cielo e velati da quella che sembrava una lancinante
compassione.
“Andremo lontano dal lago e dai
mulini. Possiamo ricominciare insieme.”
Milo non parlava. La fissava con
aria contrariata, come se l’idea di muovere anche un solo passo lo scocciasse e
intaccasse i suoi progetti.
“Io partirò comunque” proseguì Agatha,
recuperando parte della sua autorevolezza. “Puoi decidere di venire con me,
oppure di essere solo.” Parlava in tono duro, i lineamenti resi spigolosi dalla
collera, ma, quando fece una pausa, il suo viso si addolcì, e gli occhi si
fecero umidi mentre, in un estremo tentativo, aggiungeva: “La scelta è tua. Ma
io ti sto pregando: torna da me.”
Milo deglutì mentre continuava a
guardarla – sentiva la bocca asciutta. Spostò gli occhi sul dipinto che stava
ultimando, poi sui mulini al di là del parapetto, poi di nuovo su Agatha.
Lentamente, allungò le dita verso di lei e le prese la mano.
*
Una giornata tersa. Uno stormo
di uccelli che si librano nell’azzurro. Un uomo in piedi su un ponte, che porta
vestiti sdruciti e una lunga barba incolta. Ha le mani devastate dai calli e le
unghie sporche di colore; guarda verso l’orizzonte, ammiccando e stringendo gli
occhi, e cerca di intravedere tra le pale dei mulini due parole che vi sono
rimaste intrappolate tanto tempo fa. Non vuole liberarle dalla tirannia dei mulini,
né tentare di riprendersele: vuole solo essere certo che siano lì, perché
significherebbe che una parte di Agatha non è mai andata via.
Poi Milo si siede, afferra un pennello, sorride e torna a dipingere.
Bibliografia
Ovidio, Metamorfosi, libro I, tr. it. di P. Bernardini Marzolla, Einaudi, Torino, 2015
Esiodo, Teogonia, tr. it. di G. Arrighetti, BUR, Milano, 2020
Michelangelo, Rime, a cura di P. Zaja, Rizzoli, Milano, 2010
Pierre de Ronsard, Premier livre des amours, intr., bibl., relevé de variantes, notes et lexique par Henri Weber et Catherine Waber, Paris, Garnier, 1963
Snorri Sturluson, Edda, a tr. it. di G. Dolfini, Milano, Adelphi 2019
Bibbia, Genesi I, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006