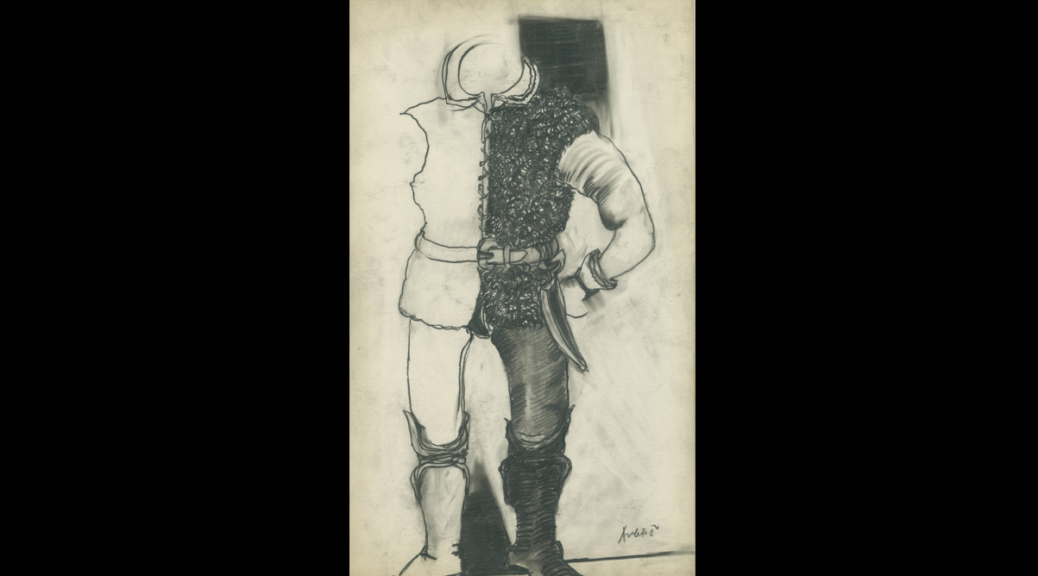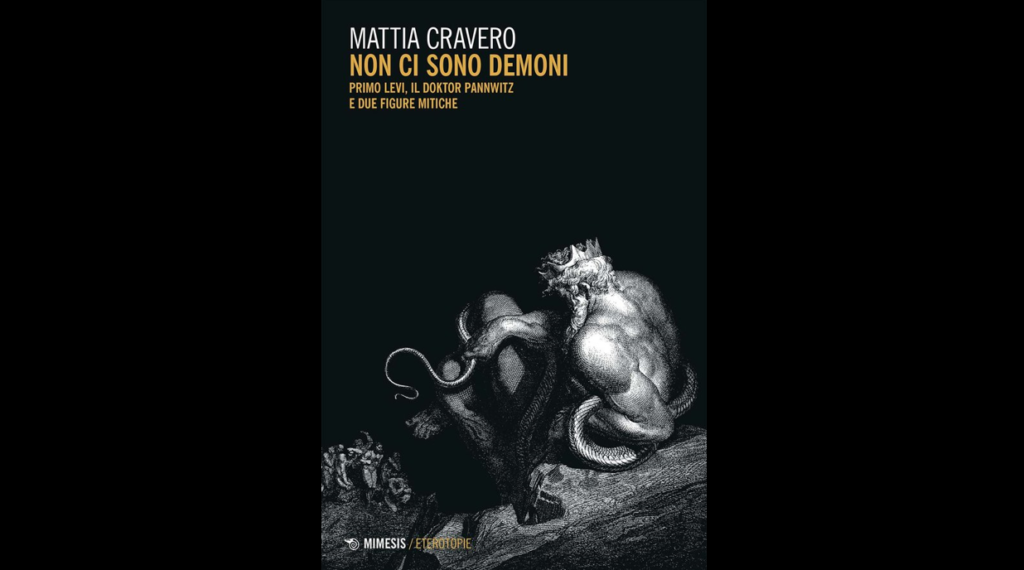
“Sarà chiaro, a questo punto che Levi ricorre al mito come risorsa retorica della sua narrazione: lo riporta, nei casi che abbiamo analizzato, come una citazione tramite similitudine o metafora resa pressoché ovvia o quasi agli occhi del lettore, ma tenuta comunque a latere del discorso. In Se questo è un uomo in particolare c’è un contesto citazionale del mito classico in cui vengono disposti richiami iconici e icastici, diretti ma allo stesso tempo silenti, che puntellano l’opera. Sono fugaci rimandi classici fittamente intessuti nella trama dell’opera e fondamentali per la sua comprensione; solo il lettore può coglierne il mistero e tentare di scioglierlo, attivando il dispositivo intertestuale che fa luce sul vero significato di ciò che le parole di Levi vogliono dire”.
da Non ci sono demoni. Primo Levi, il Doktor Pannwitz e due figure mitiche di Mattia Cravero, Mimesis, Milano, 2021, pp. 85, p. 51.