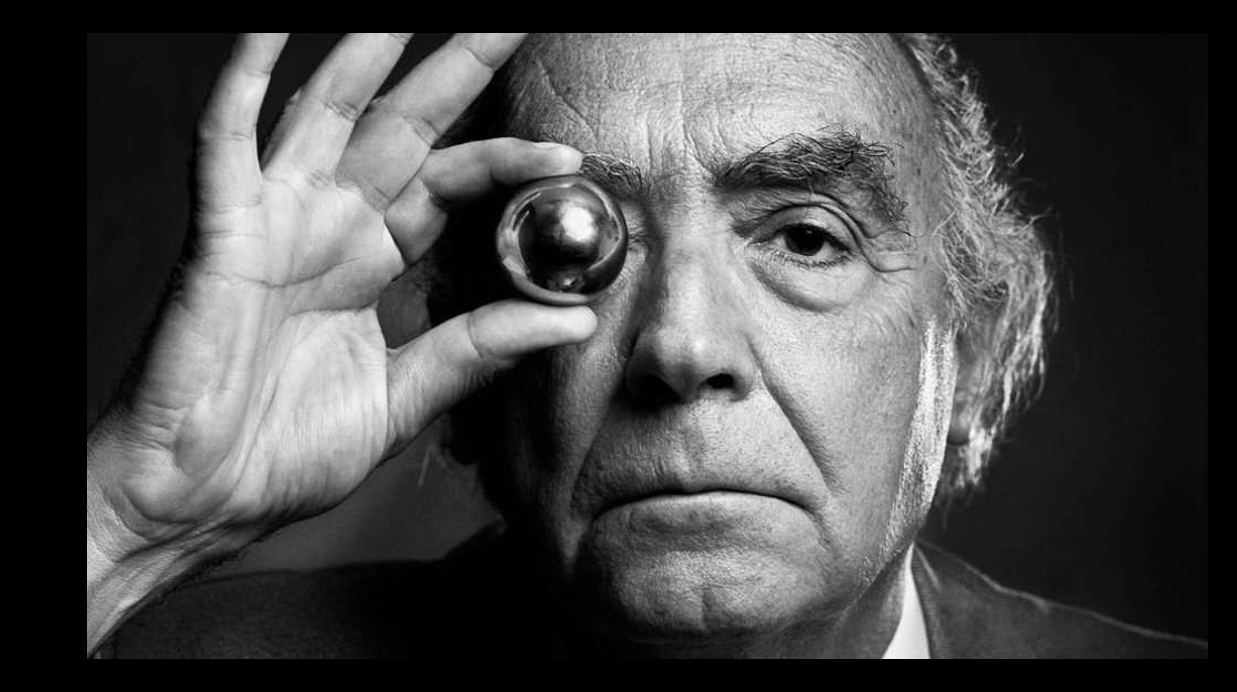Il blog è diviso in cinque sezioni:
- RISCRITTURE: pensato per la pubblicazione e la divulgazione dei lavori di riscrittura composti dagli studenti all’interno dei seminari di affiancamento ai corsi triennali; la sezione ospita al suo interno una rubrica dedicata alle riscritture di gruppo e alle pièces teatrali prodotte nel corso del seminario Riscrittura e drammatizzazione dei testi che si svolge parallelamente al corso di Letterature comparate del Dipartimento di Studi Umanistici di UniTo.
- LETTURE: ospita recensioni di opere letterarie e brevi interventi di approfondimento d’impostazione critica; la sezione ospita al suo interno la rubrica Segnali/Excerpta dedicata alla divulgazione e alla recensione di recenti saggi di critica usciti nel corso dell’anno.
- ARTI: ospita recensioni e articoli di approfondimento di mostre, spettacoli, performances e progetti multimediali offerti nella città di Torino e dintorni, per avvicinare le studentesse e gli studenti di Unito e tutta la cittadinanza alle offerte culturali del territorio. La sezione è divisa nelle due rubriche Teatro, Danza, Performances e Mostre, Exhibitions, Curatele
- NEWS: ospita notizie e aggiornamenti relativi a call for papers e convegni di ambito critico, letterario e comparatistico in Italia e all’estero; la sezione ospita anche una rubrica dedicata agli aggiornamenti sul dottorato in Lettere presso l’ateneo torinese e altri atenei italiani ed esteri.
- PROGETTI: ospita quattro pagine dedicate a progetti creativi, scientifici e di divulgazione nati intorno alla materia di Letterature comparate. La Torino di Primo Levi è un progetto pensato e realizzato dal dottor Mattia Cravero per condividere online una mappa letteraria e interattiva della Torino di Primo Levi; Diari d’Erasmus è una rubrica che ospita resoconti diaristici delle esperienze Erasmus degli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici di UniTo; Foyer Shakespeare è un ciclo di incontri dedicato all’opera di Shakespeare, alla sua interpretazione e messa in scena che si svolge nel corso dell’anno accademico nell’ambito del progetto didattico “Nothing like the Sun – Leggere, tradurre, insegnare e rappresentare Shakespeare in Italia”; Call for Short Narrative & Poetry è una rubrica dedicata alla scrittura creativa che offre alle studentesse, agli studenti e a tutta la cittadinanza la possibilità di cimentarsi con la scrittura e con la produzione letteraria