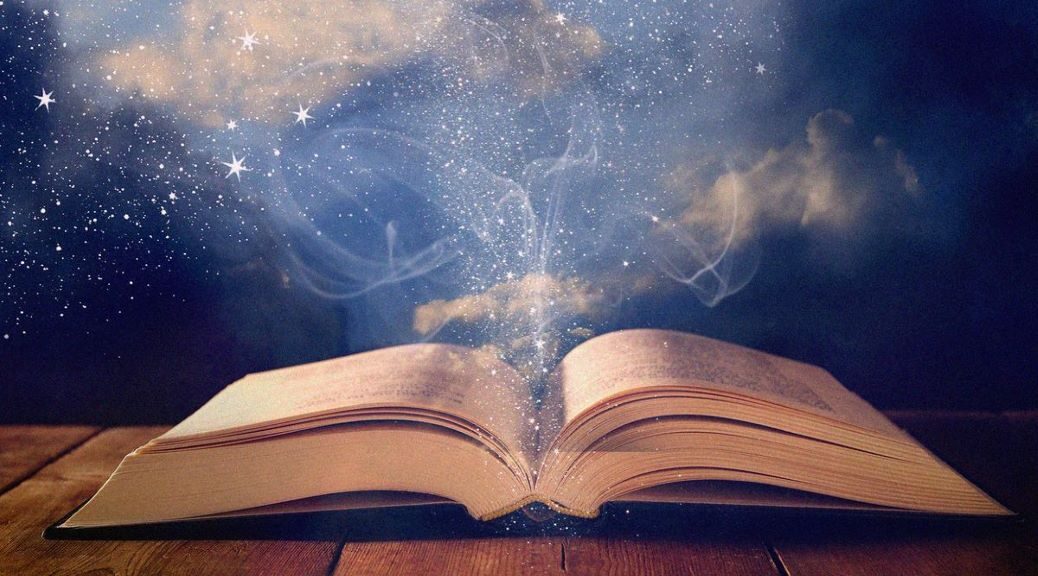Giulia Repetto, in queste due lettere, riscrive il romanzo Delitto e castigo trattando il tema della coscienza in relazione all’attuale conflitto tra Ucraina e Russia, nell’ottica del corso diLetterature comparate B, Verità e coscienza. Narrativa, poesia, teatro (Prof.ssa Chiara Lombardi).
“Se avessi voluto aspettare che tutti fossero diventati intelligenti, sarebbe passato troppo tempo… Poi ho capito anche che questo momento non sarebbe arrivato mai, che gli uomini non cambieranno mai e che nessuno riuscirà a trasformarli e che tentar di migliorarli sarebbe fatica sprecata!” (F. Dostoevskij, Delitto e castigo)
*
Rodion Romanovič Raskol’nikov
Mariupol, 18 marzo 2022
Sof’ja Semënovna Marmeladova
Cara Sonja,
come stai? Come stanno tuo padre, Katerina Ivanovna e i bambini? Alla fine i soldi sono bastati a comprare le scarpine a Pòletschka e a Lènja? Quelle che avevano erano tutte a pezzi. Hai avuto notizie di mia sorella e di mia madre? Dì a Dunja di non stare in pensiero per me.
In questo momento mi trovo nella regione della Priazovia, nella città di Mariupol. È una bella giornata, ma la polvere della devastazione offusca l’occhio del cielo e quelli che un tempo erano tranquilli sobborghi e villaggi sono diventati cumuli di macerie. Nella desolazione della guerra la desolazione della natura: gli alberi sono spogli, nelle aiuole delle piazze spuntano qua e là, piegati su loro stessi, degli esili fili d’erba e l’acqua fredda e sporca del fiume Kal’mius trasporta i detriti delle case. Oltre al vociare dei soldati e al rumore dei caccia militare, ogni tanto si sente il latrato di qualche cane in lontananza. Mi manca sentire il canto degli uccelli. Il bubbolio della guerra mi accompagna anche nel sonno; non ricordo più quale pace può esserci nel silenzio. Sonja, mia cara, anche l’odore qui è quello della guerra, della guerra e della morte, un odore che punge il naso ma a cui ormai sono abituato. Aguzzando lo sguardo riesco ancora a scorgere due colonne di fumo nero che provengono dal teatro cittadino che abbiamo bombardato ieri. Il posto è spaventoso, ma in compenso tranquillo. Il fuoco ucraino è cessato da qualche ora: i nemici stanno sicuramente piangendo i loro morti.
Non piangere Sonečka, tutto ciò è necessario. Credi che Licurgo, Solone, Maometto e Napoleone si siano fatti qualche scrupolo? E Putin? Non è forse la stessa cosa? Perché dovrei preoccuparmene io, io che eseguo solo gli ordini, io che contribuisco alla grandezza della mia patria? Dopotutto non sono anch’io un grande uomo? Io non voglio essere un uomo ordinario; voglio essere un uomo straordinario. Mentre i primi si limitano a conservare il mondo e ad aumentarlo numericamente, i secondi lo muovono e lo conducono verso la meta. Ricordi cosa avevo scritto in quel mio articoletto? Gli uomini si suddividono in due categorie: la categoria inferiore, quella degli uomini ordinari, che è composta di materiali che servono unicamente a procreare individui simili a loro, e quella degli uomini veri e propri, che hanno il dono o la capacità di dire nel loro ambiente una parola nuova. Alla prima categoria appartengono quegli uomini conservatori e morigerati che vivono nell’obbedienza, la quale per loro non è una cosa umiliante, mentre alla seconda categoria appartengono i sovvertitori, coloro che, per attuare la propria idea, si autorizzano in animo loro a passare oltre il sangue senza scrupoli di coscienza. L’uomo straordinario ha un suo diritto personale di permettere alla propria coscienza di superare certi scogli. Perché allora dovrei farmi fermare da certi ostacoli morali? Sì, ho ucciso in questa guerra, ma erano tutti soldati ucraini, nemici. Era necessario, capisci?
Tuttavia proprio questa mattina è successo qualcosa a cui non riesco a smettere di pensare da tutto il giorno. Devi sapere che qui il servizio più penoso tocca alla vedetta posta sul confine, compito che la scorsa notte è toccato a me. Avevo quasi finito il mio turno quando all’improvviso, al primo chiarore dell’alba, la tranquillità fu rotta. Ho sentito un lieve fruscio provenire da dietro un arbusto. Mi sono avvicinato con il cuore che batteva all’impazzata. Ero convinto fosse una spia ucraina, invece era solo un’anziana. Il suo volto mi è rimasto sorprendentemente impresso: era solcato da rughe profonde, accentuate dalla polvere che vi si era insinuata, e anche i capelli grigi erano ricoperti dal fango e dalla sporcizia. Gli zigomi impressionantemente sporgenti, accentuati dall’eccessiva magrezza del viso, e la pelle olivastra, macchiata da ore di esposizione ai raggi solari, non facevano che accentuare l’età avanzata della donna. I vestiti erano di ottima fattura, ma logori e strappati, e, nonostante la temperatura non fosse molto bassa, si stringeva stretta stretta in uno scialle rosso impreziosito da ricami dorati che riflettevano la luce del sole. Era molto bassa, rattrappita, accartocciata su se stessa, evidentemente consumata dalla guerra. Non si è accorta subito della mia presenza. Sono rimasto a guardarla cercare qualcosa tra i cespugli per quello che mi è parso un lasso di tempo infinito, indeciso sul da farsi. Quando si è voltata i suoi occhi color ghiaccio, incorniciati da folte sopracciglia, mi hanno colto alla sprovvista. Vi ho letto la paura. Poi la morte. L’ho uccisa, Sonja. So cosa starai pensando mentre leggi queste parole: era solo una povera innocente. La guerra è spietata Sonja, ma tu cosa puoi saperne? Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Poco importa se siano soldati o no; sono pur sempre nemici. I grandi uomini non si fermano davanti al sangue, neppure dinanzi a quello degli innocenti.
Ti confesso però che la mente mi gioca brutti scherzi: ogni volta che chiudo gli occhi mi sembra di rivedere il suo volto. Non so perché mi abbia colpito in questo modo. Era solo una donna qualunque, una vita come le altre, eppure provo pietà nei suoi confronti e soffro quando penso a lei. Dopotutto la sofferenza è l’inevitabile dovere di una coscienza generosa e d’un cuore profondo. Credo che gli uomini veramente grandi debbono provare su questa terra una grande tristezza.
Ora devo salutarti perché la Russia ha bisogno di me. Aspetto tue notizie.
Con affetto,
Rodja
Castigo
Rodion Romanovič Raskol’nikov
Sof’ja Semënovna Marmeladova
Mia cara Sonečka,
sono passati giorni dall’ultima lettera che ti ho scritto, ma non ho ricevuto tue notizie. Probabilmente non l’avranno nemmeno spedita e forse è meglio così perché la tua anima è troppo innocente e candida per essere macchiata dalle mie colpe. Non so perché mi sia preso la briga di procurarmi carta e penna per scriverti queste ultime parole dal momento che so già che non riceverai mai questa lettera. Nonostante ciò, anche solo scrivere il tuo nome mi fa sentire più vicino a te. Sonja, tu sei la mia luce in un abisso di ombre che ormai mi ha ingoiato.
Nella mia solitudine l’unica cosa che mi conforta è rileggere l’undicesimo capitolo del Vangelo di San Giovanni, quello della resurrezione di Lazzaro, perché mi ricorda quando fosti tu a leggermelo. Ho tutto chiaramente impresso nella memoria: la stanza giallastra e sudicia, il Nuovo Testamento tutto consumato, il canale che si intravedeva dalle finestre e il mozzicone di una candela che con la sua luce calda sembrava voler illuminare solamente il tuo volto, l’unica cosa degna di essere rischiarata in quella miseria.
In questo momento non saprei dirti dove mi trovo con esattezza; l’unica cosa che so è che sono in una cella russa. Sì, hai capito bene: russa, non ucraina. Ti chiederai come ci sono finito… ti accontento subito: era passata una settimana da quando avevo ucciso la vecchia e da allora la mia coscienza aveva iniziato a farsi ogni giorno sempre più pesante. Ormai il peso si era fatto insostenibile e, in un attimo di follia, sono fuggito senza una meta né un obiettivo. Non volevo scappare dalla guerra, o almeno non consciamente. Volevo scappare dai miei pensieri, dalla mia coscienza, forse addirittura da me stesso. Sapevo solo che dovevo allontanarmi da lì, ma mentre lo facevo i miei pensieri mi inseguivano e anche se provavo a correre più velocemente, loro tenevano il passo con me. Vedendo che era tutto inutile, stremato dalla corsa disperata, mi sono lasciato cadere al suolo nella leggera stanchezza del mezzogiorno. Da qual momento i miei ricordi sono confusi: ho sentito delle persone sopraggiungere di corsa, delle voci, qualcuno mi ha sollevato di peso e mi ha trasportato fino a qui. In Russia non siamo molto clementi con i disertori, quindi non so perché non mi abbiamo giustiziato subito, ma so che la fine è dietro l’angolo. Anche in questo momento riesco a percepire il respiro della Morte sul mio collo. È dietro di me, la sento, aspetta solo di potermi trascinare all’inferno con lei. Forse sarebbe stato meglio se mi avessero sparato subito, almeno mi sarei risparmiato tutto ciò. Essere rinchiuso in questo buco da solo con i miei pensieri mi sta facendo impazzire. Vivo in un perenne stato febbrile a cui alterno brevi momenti di lucidità, come questo. I secondi scorrono lenti come ore e ho perso completamente la cognizione del tempo. Non riesco a mangiare, non riesco a dormire, in alcuni momenti mi sembra di non riuscire nemmeno a respirare perché un peso mi schiaccia il cuore e mi lascia senza fiato. Ogni volta che chiudo gli occhi vedo il volto di quella vecchia e vi riconosco quello di tutte le altre persone che ho ucciso. Ogni notte in sogno rivivo quel momento e mi risveglio madido di sudore e con il cuore in gola.
La scorsa notte, dopo essermi destato di soprassalto, attraverso una minuscola feritoia, l’unica che c’è, ho intravisto una luna piena e rossa come mai ne ho viste in vita mia e davanti a quello spettacolo della natura per la prima volta dopo molti mesi ho provato una sensazione di pace. I raggi lunari si facevano strada attraverso le sbarre della piccola finestrella illuminando soffusamente lo spazio circostante la mia branda. Il silenzio sembrava assoluto, ma aguzzando meglio le orecchie si riuscivano a udire in lontananza i colpi dei bombardamenti. La brezza primaverile della notte sembrava avvolgermi e per un attimo ho dimenticato la mia condizione, ma quando ho abbassato lo sguardo un urlo spontaneo mi è sorto direttamente dalle profondità dell’animo. Le mie mani erano macchiate del sangue della vecchia e di tutte quelle persone, soldati e civili, che avevo assassinato. Reso pazzo dalla disperazione ho provato a lavarlo via, ma nulla sembrava funzionare, anzi più provavo a sfregarlo più la macchia rossa sembrava allagarsi e l’odore metallico del sangue entrarmi nelle narici. Dopo quelle che mi sono parse ore, stremato e sconfitto, sono ricaduto in un sonno tormentato. Al mattino tutto era svanito, ma il cuscino era ancora bagnato dalle mie lacrime. Quel sangue c’era davvero? Era un effetto ottico provocato dalla luce lunare? O me lo sono immaginato? Credo che la pazzia si stia impossessando della mia mente. O forse sono già completamente impazzito e non me ne rendo conto.
La carta è quasi finita quindi devo concludere questa lettera. Da’ a mia madre e a Dunja un bacio da parte mia e promettimi che ogni tanto passerai a trovarle e che ti occuperai di loro se necessario. Abbraccia Razumichin e digli che è stato un buon amico e che lo ammiro molto: è sempre stato tutto che volevo diventare e che mi illudevo di essere. Quanto a te, Sonja, ti ho voluto molto bene. Spero che conserverai per sempre quell’innocenza così pura che mi ha colpito di te. Non piangere per me, non me lo merito.
Addio Sonja
Rodja
*
Bibliografia selezionata:
F. Dostoevskij., Delitto e castigo, a cura di D. Rebecchini, Feltrinelli, 2013
W. Shakespeare, Macbeth, in Tutte le opere. Vol. 1: Le tragedie, a cura di F. Marenco, Milano, Bompiani, 2015